
PCV2 parliamone
Consigli tra scienza ed esperienza
di Enric Mateu
Estratti degli interventi agli incontri, organizzati da MSD Animal Health Italia, di Enric Mateu, Professore Titolare del Dipartimento di Sanità ed Anatomia Animale, Facoltà di Veterinaria, Universitat Autònoma de Barcelona e Dottore in veterinaria presso la UAB.
Le sue ricerche si concentrano sulle malattie infettive dei suini ed è autore di numerosi articoli nazionali ed internazionali su questi temi. E’ responsabile del servizio di diagnostica di laboratorio delle malattie infettive della UAB.
Guarda le brevi video-pillole di seguito, per ripercorrere le tappe fondamentali dell’evento.
Sindrome da deperimento (PMSW), forme regionali, forme riproduttive, si discute tanto su come sia cambiata la sintomatologia da PCV2.

Partiamo dal presupposto che la comunità scientifica ha escluso l’esistenza, se non in forme rare, di forme esclusivamente respiratorie o esclusivamente enteriche.
Secondo la mia esperienza, la malattia si comporta più o meno come 20 anni fa. Con copertura immunitaria adeguata, i segni clinici sono assenti o poco evidenti, mentre in caso di copertura anticorpale insufficiente, si rischia una manifestazione sistemica. Un’altra questione è come l’infezione da PCV2 possa essere sinergica con altri agenti virali come il PRRSV o i batteri e come ciò possa modificare l’espressione clinica della malattia in allevamento. Dovremmo indagare questo aspetto.
Il contenimento della possibile sinergia tra PRRSv e PCV2 è cruciale.

Da molti anni è dimostrato che quando un animale si infetta con PRRSv e PCV2 la situazione è più grave. PRRSv incrementa la replicazione di PCV2, infatti di norma, anche in allevamenti in cui si vaccina correttamente, il problema non è PCV2 ma PRRSv. Cercare di controllare PRRSv, controllare la correttezza del piano di vaccinazione per PCV2 sono i punti cruciali.
Per poter diagnosticare un reale quadro di malattia da PCV2 spesso ci si chiede se i criteri diagnostici utilizzati siano corretti.
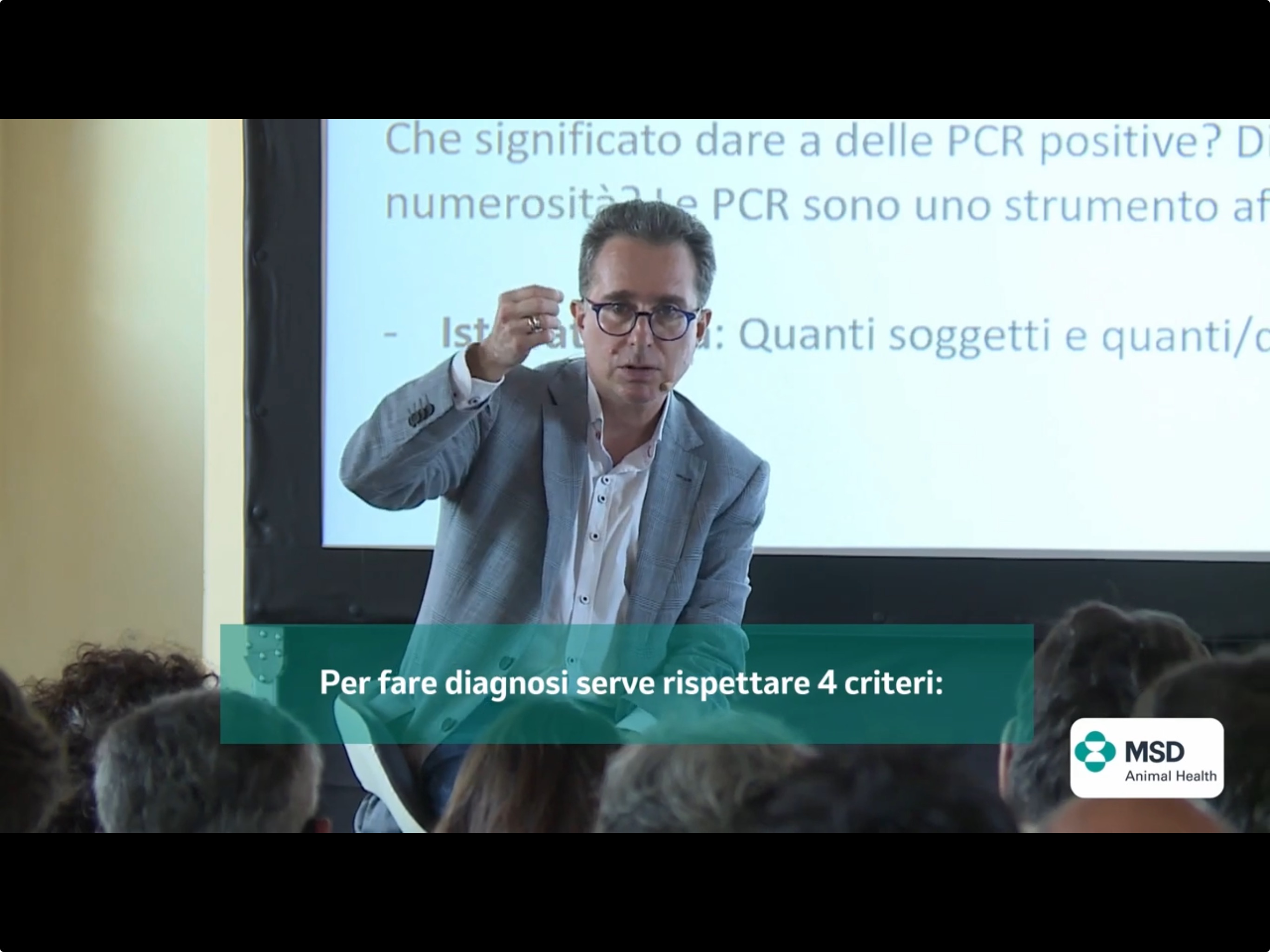
L’epidemiologia della malattia è cambiata rispetto a quella degli anni ‘90-2000. A complicare ancora di più la diagnosi, ci si mettono i ceppi iperpatogeni di PRRSv che rendono la sintomatologia clinica facilmente confondibile.
Questi ceppi danneggiano il timo provocandone la deplezione linfocitaria che, seppure transitoria, porta ad un quadro istologico che può somigliare a quello del PCV2. E anche quando si esaminano le lesioni a livello di linfonodo per ricercare il PCV2, talvolta non si trovano o si trovano poco. Detto questo, ritengo affidabile una diagnosi di PCV2 solo quando vengono valutati insieme epidemiologia, quadro clinico, lesioni e presenza/quantità del virus.
Di fronte a una malattia multifattoriale, non potendo agire su tutto, è fondamentale considerare i principali fattori di
rischio.
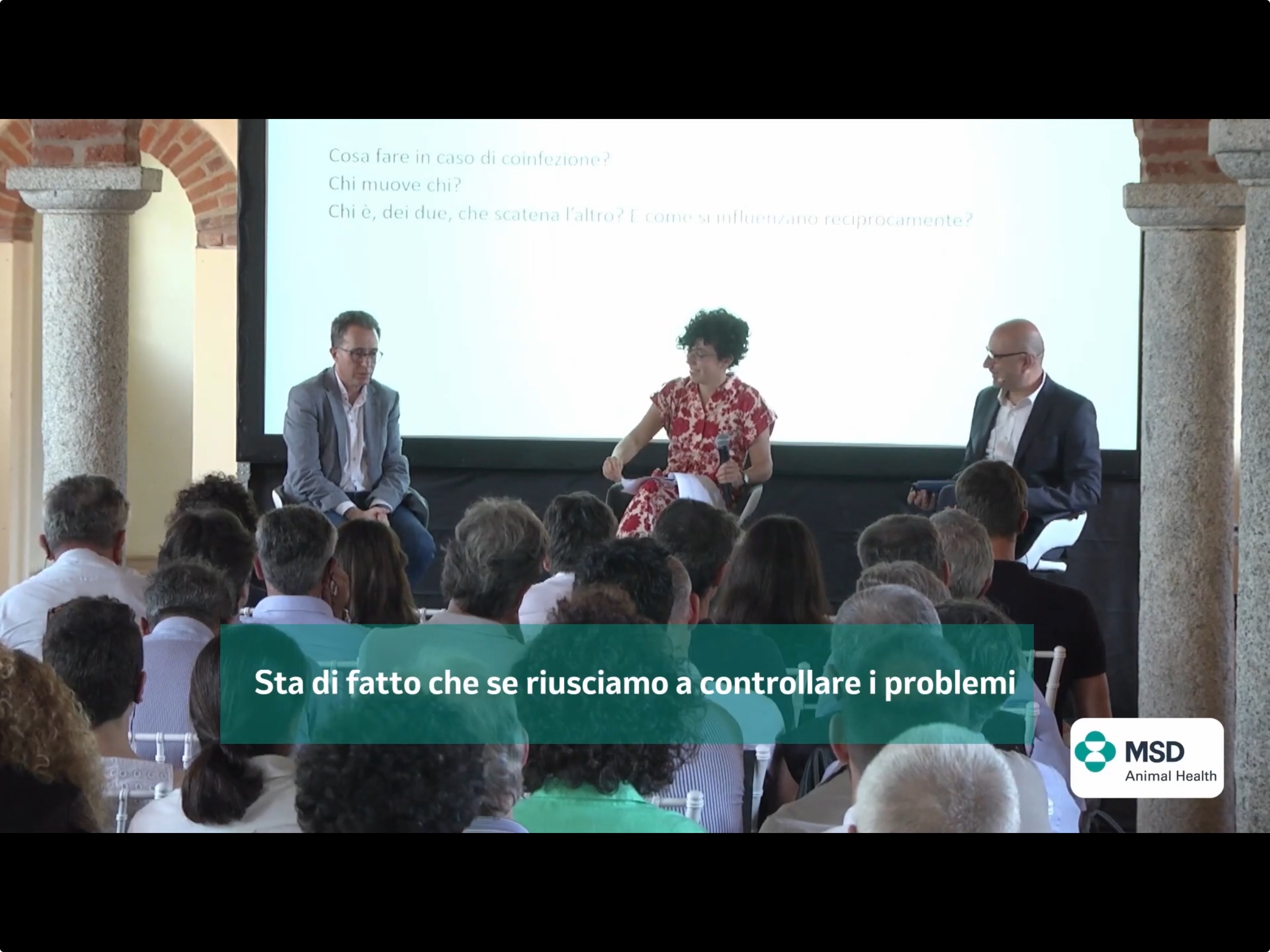
Per tutti i fattori che modificano la replicazione dei linfociti, poichè il
PCV2 si replica molto attivamente nei linfoblasti, è fondamentale:
- Migliorare il benessere animale, importantissimo nella genesi di malattie come PRRS e Circovirosi
- Controllare gli altri patogeni
- Curare l’acclimatamento dei riproduttori.
Concentrarsi su questi 3 punti però non ci permette di stare al sicuro se
non abbiamo il controllo del flusso di produzione.
Un allevamento che non controlla i flussi di produzione non sarà in grado
in alcun modo di controllarne la sanità.
Talvolta vediamo la sindrome da deperimento (PMSW), ma i
risultati della diagnostica di laboratorio non ci aiutano. Altre
volte i risultati di laboratorio ci farebbero pensare a una
sintomatologia da PCV2 che però alla fine non si evidenzia.

Un conto è il monitoraggio in allevamento, un conto è la diagnostica in allevamento.
La premessa iniziale è che per parlare di malattia da PCV2 ci debba
essere la manifestazione clinica. Se questa non c’è, o si tratta di un’infezione
subclinica o siamo di fronte a un semplice “monitoraggio”, che di
per sé può avere senso se prima ci chiediamo perché lo vogliamo applicare
e, soprattutto, che azioni metteremo in atto con tutti i dati che otteniamo.
Spesso è un buco nell’acqua, in quanto per fare diagnosi di un problema
in allevamento, quando si valuta bisogna rispettare 4 criteri:
- Epidemiologia
- Clinica individuale
- Istopatologia
- Quantità del virus (IHC, IHS)
La forma subclinica è un tema ricorrente, così come il danno
che può portare al ciclo di produzione.
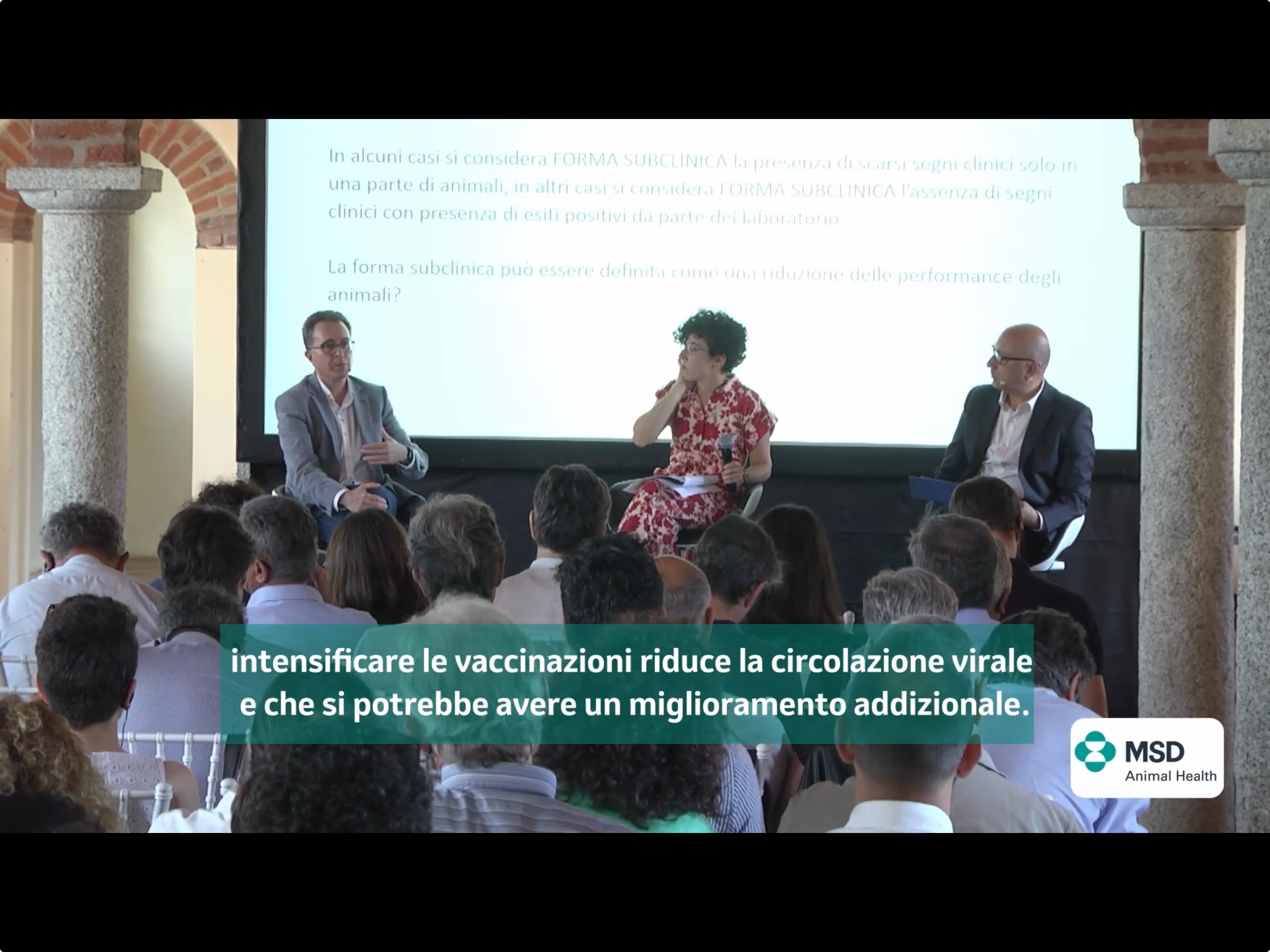
Non essendoci immunità sterilizzante, potremmo avere un’alta prevalenza di forme sub-cliniche. Sono le forme più frequenti, si risolvono in 3-4 settimane e, anche se moderatamente, possono avere un impatto negativo sulla produzione.
Dopo l’esperienza con il Covid-19 è chiarissimo a tutti che un’immunità non sterilizzante, come quella indotta dai vaccini verso Circovirus e Coronavirus,
può permettere nuove infezioni ma abbassare o azzerare sia la manifestazione clinica che la circolazione virale, diminuendo il rischio epidemiologico in allevamento.
E’ questo il fattore importante su cui concentrarsi.
Quella contro PCV2 è da troppo tempo una vaccinazione
“Core”. Ci si chiede se debba cambiare l’aspettativa di efficacia.

Alcune persone dicono che il vaccino X sembra funzionare un po’ meglio del vaccino Y, ma poi ne incontri altre che ti dicono l’esatto contrario.
Le aspettative sono sempre semplicistiche: «vaccino e non voglio vedere la malattia». La domanda da porsi quando si trova la malattia in animali
vaccinati è una e una sola: «la vaccinazione è stata effettuata correttamente?».
Secondo la mia esperienza, in caso di fallimento del vaccino, la prima causa
da indagare è se il vaccino sia stato somministrato adeguatamente. Oltre
a ciò, occorre verificare anche la tecnica di vaccinazione e la corretta conservazione dei vaccini. La maggior parte dei fallimenti vaccinali sono
causati da un fattore umano.
I virus si evolvono. È importamte capire quanto questo aspetto sia cruciale nella strategia di controllo del PCV2.
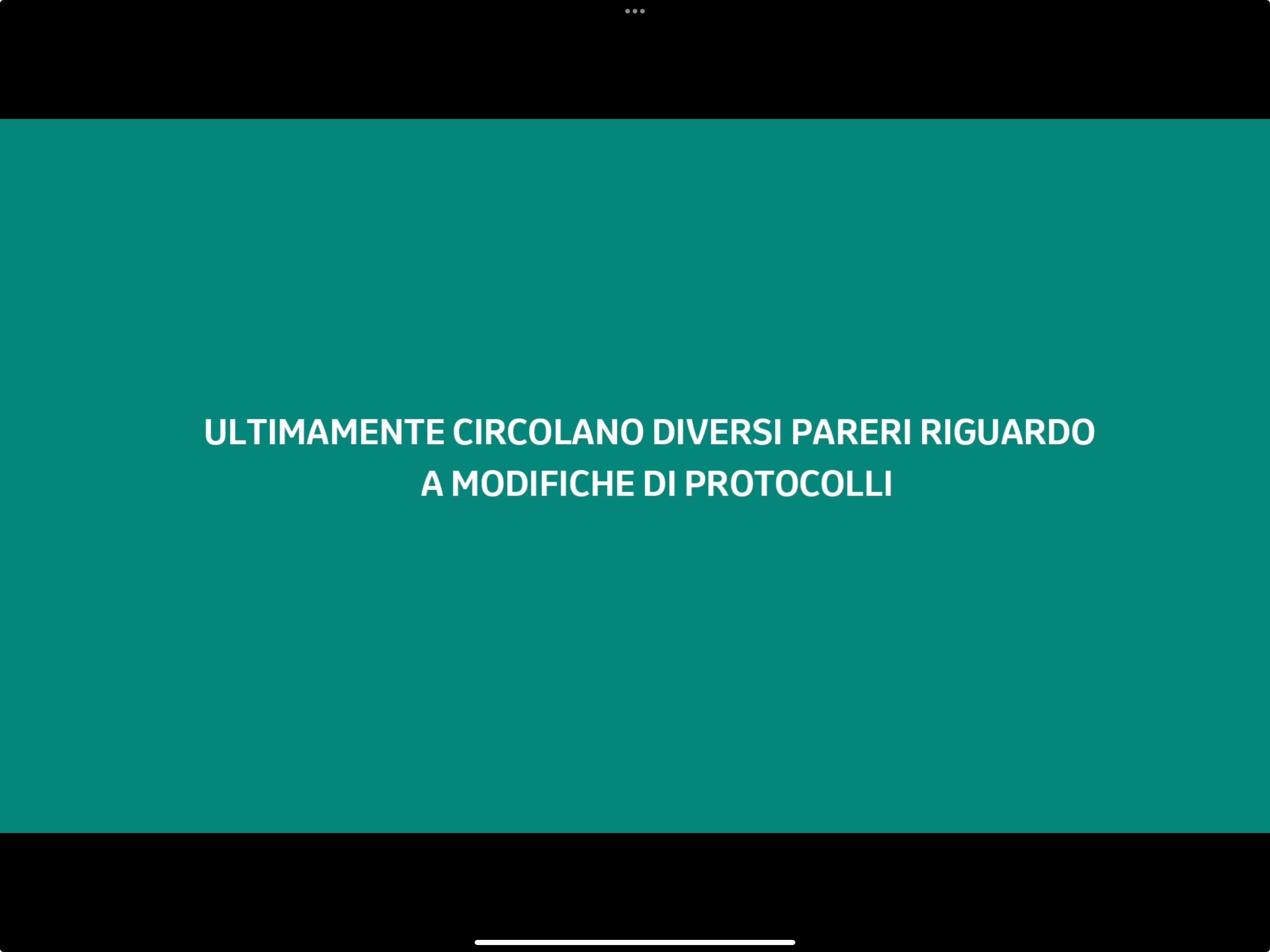
I vaccini attualmente in commercio conferiscono una buona protezione nei confronti dei genotipi circolanti oggi. Come detto più volte, il focus va posto sul fattore umano riguardante la gestione del vaccino e l’atto della vaccinazione in allevamento.
Ultimamente circolano diversi pareri riguardo a modifiche di
protocolli che prevedano interventi vaccinali da aggiungere a quelli dei suinetti sottoscrofa.

Sulle vaccinazioni delle scrofe possiamo fare tanti ragionamenti tecnico-scientifici, ma uno su tutti regna: dato che il costo della vaccinazione per PCV2 nella scrofa è basso, inserirla per la protezione delle scrofe o della progenie può avere un senso. Dobbiamo solo accertarci che sia inserita all’interno di protocolli semplici, applicabili e sostenibili nel tempo.
Per la seconda vaccinazione per PCV2 nel ciclo di produzione dell’allevamento del suino pesante italiano, non scarterei l’ipotesi che questa pratica, finalizzata all’allungamento della copertura anticorpale, possa portare vantaggi.
A volte si cerca di proporre piani di monitoraggio contro le
varie malattie infettive e spesso ci si chiede quale sia il
migliore e se ha senso farlo per PCV2.

Prima di proporre piani di monitoraggio, dovremmo avere bene in mente quale sia l’obiettivo primario e come pensiamo di gestire i dati che arriveranno.
Talvolta arrivano molti dati, ma non si è in grado di raggrupparli, analizzarli e trarne delle conclusioni per attivare un piano d’azione. Ad esempio, fare un monitoraggio per capire se e quando iniziare a vaccinare?
Oppure per capire cosa sta realmente succedendo? Se non c’è un chiaro e
preciso obiettivo e scenari di azione, si rischia di agire in maniera reattiva e non razionale quando si ricevono dei dati.
